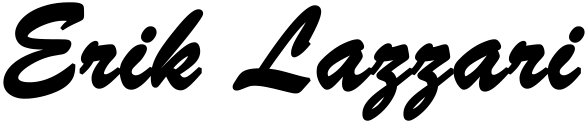“Se solo avessi un gadget magico che risolvesse tutto…”
Quante volte ci siamo trovati a pensarlo? Doraemon dà forma proprio a questa fantasia, ma ci invita anche a riflettere sul perché desideriamo così tanto evitare la fatica e il dolore dell’impegno.
Doraemon e la psicologia: analisi dei legami tra crescita, fallimento e dipendenza
Quando si pensa a Doraemon, il celebre gatto robot giapponese creato da Fujiko F. Fujio, si tende a classificarlo come un semplice cartone animato per bambini; in realtà, dietro le sue storie leggere e i suoi chiusky miracolosi, si cela una narrazione profonda, capace di parlare alle fragilità umane e ai sogni di riscatto.
In questo articolo viene analizzato Doraemon da un punto di vista psicologico, evidenziando i temi di insicurezza, dipendenza affettiva, pressione sociale e desiderio di autoaffermazione.
Nobita: l’incarnazione dell’insicurezza e dell’evitamento
Nobita vive una condizione di autopercezione negativa costante. È l’anti-eroe per eccellenza. Svogliato, goffo, costantemente in difficoltà sia a scuola sia nella vita sociale, rappresenta il bambino (ma anche l’adulto) che teme il giudizio, rifugge la responsabilità e cerca scorciatoie per evitare il fallimento. È un personaggio che vive nel costante conflitto tra il desiderio di migliorarsi e la paura di non essere all’altezza. Questa visione di sé è talmente interiorizzata da trasformarsi in una vera profezia che si autoavvera: fallisce perché si aspetta di fallire.
Dal punto di vista psicologico, Nobita presenta tratti di insicurezza cronica, bassa autostima e una forte tendenza all’evitamento attivo: ogni problema lo paralizza, ogni ostacolo lo spinge a fuggire piuttosto che affrontarlo. È un personaggio tragico nella sua umanità, che trova in Doraemon sia un alleato che un vero e proprio sostegno psico-emotivo.
Doraemon: genitore, psicoterapeuta e guida morale.
Doraemon è la figura del genitore ideale: paziente, presente, protettivo. È l’adulto che tutti vorremmo nei momenti difficili. Non è, infatti, solo un robot: è una figura genitoriale sostitutiva, un “super-io” benevolo che interviene per riportare Nobita sulla giusta strada, ogni volta che questi cade. Sebbene sia un robot, prova sentimenti autentici e l’innamoramento per Mi-chan (la gatta) ne è la conferma.
Con la sua tasca magica, Doraemon fornisce strumenti che, almeno in apparenza, permettono di aggirare il problema. In realtà, ogni chiusky è anche un test: come lo userà Nobita? Ne abuserà, come spesso accade, o riuscirà finalmente a crescere?
Doraemon è altresì l’emblema della sovra-protezione, infatti rinforza il comportamento passivo di Nobita, riduce la sua possibilità di crescita reale e fornisce strumenti che, spesso, vengono utilizzati per evitare l’impegno, non per affrontarlo.
La relazione tra Nobita e Doraemon ha molto in comune con quella tra paziente e terapeuta: Doraemon non impone, ma suggerisce. Non punisce, ma accompagna. Il legame, però, diventa talvolta disfunzionale: Nobita sviluppa una vera e propria dipendenza affettiva e operativa, delegando completamente a Doraemon la gestione della propria vita.
In termini psicologici, Doraemon è una figura d’attaccamento sicura, che può però trasformarsi in un sostituto patologico della responsabilità.
Gli altri personaggi come specchi delle dinamiche sociali
Il mondo di Nobita è popolato da figure emblematiche:
- Shizuka, una ragazza dolce, intelligente ed empatica che rappresenta il modello ideale irraggiungibile. È sempre positiva e sprona gli altri a migliorarsi. La sua presenza alimenta il desiderio di cambiamento. Nobita la ama, ma è consapevole di non meritarla e ciò causa in lui ansia e senso di inadeguatezza.
- Gian, il bullo dal cuore tenero, è la maschera dell’insicurezza che si esprime attraverso la forza. È terrorizzato dalla madre e la paura lo porta ad essere aggressivo con gli “amici”. L’aggressività maschera una fragilità interiore non riconosciuta: vuole essere temuto per nascondere la paura di essere trascurato; vuole dominare per non sentirsi dominato; canta male ma costringe tutti ad ascoltarlo e pretende approvazione dove non la ottiene.
Gian è il classico esempio di identità reattiva: sviluppa un comportamento aggressivo per coprire un Sé fragile. Nella teoria psicoanalitica, potremmo parlare di un Io compensativo che cerca potere per non sentirsi impotente.
- Suneo, il vanitoso manipolatore, è falso ma nasconde insicurezze profonde: ostenta ricchezza e status per colmare un vuoto identitario; si associa ai più forti (Gian) per proteggersi; ha bisogno costante di sentirsi superiore.
Il suo profilo psicologico somiglia a quello di una personalità narcisistica fragile: l’apparente sicurezza maschera una forte dipendenza dall’approvazione altrui.
- Dekisugi, l’amico-rivale di Nobita, è intelligente, gentile, educato, bello e bravissimo in tutto. Dekisugi incarna – proprio come Shizuka – l’ideale irraggiungibile. È il simbolo del merito, dell’impegno premiato, ma anche della frustrazione di chi non riesce a eguagliarlo. Nonostante sia sempre corretto e amichevole, la sua perfezione diventa un peso psicologico per Nobita, perché rappresenta tutto ciò che lui non è (ma vorrebbe essere).
- Le madri di Nobita e Gian, sono rappresentate come urlanti, stanche, frustrate. Sono donne che non riescono a comunicare realmente con i figli e la cui unica modalità relazionale è la sgridata.
La madre di Nobita è il simbolo di un genitore stanco e deluso, che ha rinunciato a comprendere e si limita a punire. La sua isteria è l’effetto di una frustrazione repressa, che esplode ogni giorno di fronte all’inerzia del figlio.
La madre di Gian è simile, ma ancor più tragica: pur avendo un figlio aggressivo e violento, non riesce a imporsi, e quando interviene lo fa in modo sproporzionato ricorrendo lei stessa alla violenza.
In entrambe ritroviamo il fallimento della comunicazione genitore-figlio, tipico delle famiglie dove non si coltiva un dialogo emotivo autentico.
- Gli adulti sono assenti. I genitori dei vari personaggi, gli insegnanti, gli adulti del quartiere appaiono impotenti o distanti, talvolta severi, altre volte rassegnati. Questo contribuisce a creare un mondo dove l’unico affidabile è un gatto-robot venuto dal futuro, ovvero un simbolo irreale.
L’assenza di adulti emotivamente disponibili rappresenta il vuoto educativo e la difficoltà degli adulti a comprendere la fragilità dei ragazzi.
Ogni personaggio riflette una dinamica reale, riscontrabile anche negli ambienti scolastici o lavorativi: la competizione, la paura di non essere accettati, la necessità di riconoscimento.
La scuola: luogo di giudizio, non di crescita
La scuola di Nobita è un incubo: verifiche, punizioni, voti bassi, giudizi umilianti. L’ambiente scolastico diventa una macchina ansiogena, che produce frustrazione invece di apprendimento.
È una scuola senza pedagogia, dove l’errore è punito e non compreso. Doraemon diventa allora l’alternativa immaginaria a un sistema educativo troppo rigido e colma – in parte – la demoralizzazione di Nobita.
Una metafora dell’infanzia (e dell’eterno ritorno)
Un elemento chiave di Doraemon è la ciclicità: ogni episodio segue lo stesso schema. Problema → chiusky → abuso → disastro → lezione (spesso ignorata). Questo loop rappresenta il blocco evolutivo: Nobita non cambia mai davvero. È un eterno bambino, immagine della paura di crescere e della difficoltà di assumersi la responsabilità del proprio futuro. È una sorta di autosabotaggio psicologico: Nobita desidera migliorarsi, ma inconsciamente boicotta ogni tentativo di crescita.
I chiusky spesso creano una situazione peggiore di quella iniziale poiché Nobita ne abusa per evitare la realtà e non per comprenderla e affrontarla.
Il fatto che Doraemon venga dal futuro per cambiare il passato è, in sé, un messaggio molto forte: il futuro non è scritto, ma può essere modificato solo se cambiamo il presente. Doraemon è la manifestazione del desiderio di salvezza, della possibilità di migliorare. È la speranza che, pur tra mille errori, si possa ancora imparare.
Conclusione: perché Doraemon parla anche agli adulti?
Doraemon continua a emozionare intere generazioni perché è un alleato che capisce, aiuta e non giudica. Mostra le paure, i sogni di fuga, la voglia di qualcuno che risolva i problemi. Ma ricorda anche che ogni scorciatoia ha un prezzo e che crescere, affrontare la vita con coraggio e responsabilità, è l’unico modo per costruire un domani diverso.
Doraemon è anche un monito: l’aiuto esterno non può sostituire la crescita interiore. Ogni “chiusky” è una tentazione: scegliere di usarlo bene è il vero percorso di maturazione.
Il messaggio nascosto di Doraemon è potente:
Ci salviamo da soli, ma solo quando qualcuno crede in noi abbastanza da farci credere di potercela fare.