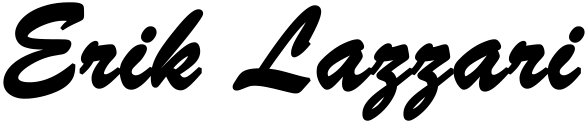La poetica di Pirandello: maschere, crisi d’identità e relativismo
La poetica come chiave di lettura dell’intera opera pirandelliana
La riflessione sull’identità, sulla relatività del reale e sull’incomunicabilità tra individuo e società è al centro della poetica di Luigi Pirandello. Ogni sua opera, che si tratti di romanzi, novelle o testi teatrali, nasce da una visione profonda e disillusa della condizione umana moderna, costretta in forme sociali rigide, incapace di esprimere l’autenticità del proprio essere.
L’autore siciliano, nei primi decenni del Novecento, aveva già compreso quelle che sono le radici della crisi dell’uomo contemporaneo.
La maschera e la forma: il dramma dell’apparenza
Uno dei concetti più noti della poetica pirandelliana è quello di maschera. L’essere umano, secondo Pirandello, è costretto a indossare una maschera sociale, ovvero un ruolo imposto dall’ambiente in cui si trova. Questa maschera coincide con quella che egli chiama forma: una struttura rigida, rassicurante ma profondamente alienante, che soffoca la spontaneità dell’individuo.
La società non tollera l’informe e l’inclassificabile, pertanto impone ruoli, etichette e identità fisse, ma l’uomo per sua natura, è molteplice, contraddittorio, fluido. La tensione tra l’essere autentico e la maschera sociale genera sofferenza, incomprensione, frustrazione.
Nel romanzo Uno, nessuno e centomila, Luigi Pirandello evidenzia molto bene tale concetto: il protagonista, Vitangelo Moscarda, scopre che l’immagine che gli altri hanno di lui è diversa da quella che egli ha di sé. Da qui il crollo dell’illusione dell’unità dell’io.
L’identità come illusione: l’io molteplice e frammentato
Pirandello rifiuta l’idea di un io coerente e stabile. L’identità, per lui, non è un nucleo immutabile ma una somma di percezioni altrui. Ogni individuo è, di fatto, uno per sé, centomila per gli altri e quindi nessuno in senso assoluto.
Questa visione anticipa, con straordinaria modernità, le riflessioni del Novecento sull’inconscio, sulla molteplicità dell’io, e sulle maschere che si indossano in ogni contesto sociale.
Il dramma dell’individuo rispecchia proprio in questa discrepanza tra interiorità e rappresentazione, tra ciò che si è e ciò che gli altri vedono. L’uomo pirandelliano è un essere in crisi, smarrito in una realtà priva di certezze.
Il relativismo conoscitivo e morale: verità plurime e instabili
Alla base della poetica di Pirandello vi è una profonda sfiducia nelle verità assolute. La realtà non è oggettiva ma costruita, relativa al punto di vista dell’osservatore. Non esiste un’unica verità, ma tante verità soggettive, ciascuna legata allo sguardo di chi osserva.
Questo relativismo conoscitivo investe anche la sfera morale: i concetti di giusto e sbagliato, di bene e male, si sfaldano, diventano categorie fluide, dipendenti dal contesto e dalla percezione individuale.
Pirandello smaschera così la presunta razionalità dell’ordine sociale, rivelandone l’arbitrarietà. L’uomo non può mai conoscere veramente l’altro, né essere compreso a fondo. Resta solo nella sua incomunicabilità, nel tentativo disperato di affermare un’identità sfuggente.
Il teatro della crisi: la poetica pirandelliana sulla scena
Il teatro di Pirandello è la forma espressiva in cui la sua poetica si manifesta con maggiore radicalità. Nel dramma Sei personaggi in cerca d’autore, l’autore rompe con le convenzioni del dramma borghese ottocentesco, introducendo una dimensione meta-teatrale e profondamente filosofica.
Nel suo teatro la realtà scenica viene continuamente messa in discussione: i personaggi si ribellano all’autore, si interrogano sul senso della finzione, sul confine tra vita e rappresentazione. Il pubblico viene coinvolto in un gioco vertiginoso di specchi, dove finzione e realtà si confondono.
La crisi dell’identità diventa crisi dell’arte, crisi della parola, crisi della rappresentazione. Il teatro non è più uno spazio chiuso, rassicurante, bensì un luogo in cui emerge il caos della vita, la sua imprevedibilità e assurdità.
Attualità della poetica di Pirandello
A distanza di oltre un secolo, la poetica di Pirandello si rivela quanto mai attuale. I temi della maschera, dell’identità fluida, della percezione frammentata di sé trovano oggi nuova linfa nei social network, nei profili virtuali, nell’esposizione costante dell’io alla visione dell’altro.
La riflessione pirandelliana ci invita a interrogarci su chi siamo davvero dietro le maschere che indossiamo ogni giorno e ci aiuta a comprendere la complessità dell’essere umano, la sua tensione irrisolta tra bisogno di autenticità e necessità di adattamento.
“La vita o si vive o si scrive, io non l’ho mai vissuta, se non scrivendola”, diceva. Ma il suo genio è riuscito a fare entrambe le cose, rivelandoci, attraverso la scrittura, l’impossibilità di vivere senza maschere.
Se ti interessa approfondire il contesto letterario dell’epoca, leggi anche il nostro articolo sul Decadentismo